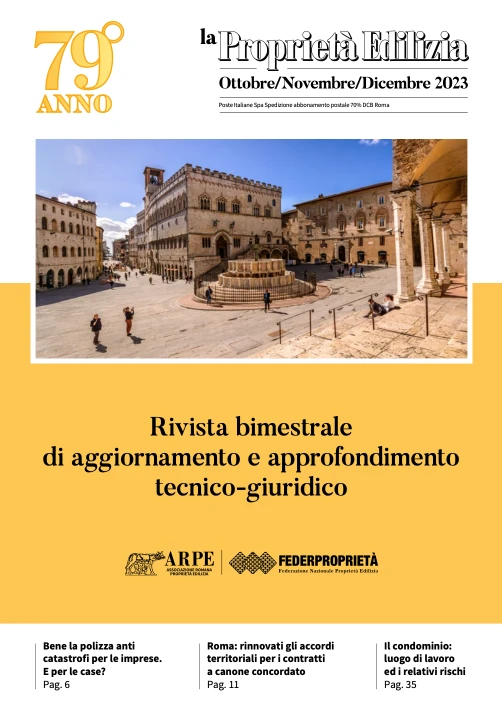Riguardo alle variegate fattispecie esistenti nella realtà, non risulta sempre di piana applicazione il disposto dell’art. 2053 c.c., secondo cui “il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”, specie con riferimento alla norma generale contemplata nell’art. 2051 c.c., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Una recente pronuncia del Supremo Collegio (v. Cass. 11 dicembre 2023, n. 34401) tenta di delineare il corretto discrimen tra queste due norme, segnatamente sul versante della natura giuridica della responsabilità in capo al proprietario e della configurazione concreta dell’eventuale prova liberatoria.
La causa originava dalla domanda proposta da un soggetto nei confronti del vicino, per sentircondannare quest’ultimo a risarcire i danni derivati al primo a seguito dell’incendio insorto nell’immobile confinante di proprietà del secondo.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea, con verdetto confermato in sede di appello.
Il danneggiato proponeva, quindi, ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 2053 c.c., e rimproverando ai giudici di merito di aver escluso la responsabilità del convenuto, atteso che tale norma prevedeva la responsabilità oggettiva del proprietario e che, nel suo paradigma, la prova liberatoria coincideva esclusivamente con il caso fortuito o la forza maggiore.
In buona sostanza, si sosteneva che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2053 c.c., inteso quale speciesrispetto al genus dell’art. 2051 c.c., per acquisire la responsabilità sarebbe stato sufficiente il titolo di proprietà della cosa.
I giudici di Piazza Cavour hanno, però, ritenuto infondate le doglianze del ricorrente.
In effetti, la recente pronuncia richiamata da quest’ultimo (v. Cass. 26 maggio 2020, n. 9694), ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2053 c.c., sembrerebbe affiancare, ad un necessario potere di fatto, la qualità di proprietario (“non bastando … un potere d’uso sulla res”).
Il potere di fatto, quale fonte dell’obbligo di custodia, “basta” per la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c.: esso, appunto, crea l’obbligo e, quindi, la responsabilità nell’ipotesi del suo inadempimento.
Tuttavia – a ben guardare – il paradigma dell’art. 2053 c.c. non è propriamente una species dell’art.2051 c.c. quale genus, il che era stato affermato da giurisprudenza anche risalente, come per esempio Cass. 29 gennaio 1981, n. 693, la quale aveva ravvisato, nella responsabilità di cui all’art. 2053 c.c.,“un’ipotesi particolare di danni da cose in custodia, onde, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce l’applicazione dell’art. 2051 c.c.”, e Cass. 16 marzo 1987, n. 2692, la quale aveva qualificato la responsabilità per rovina di edificio di cui all’art. 2053 c.c. “un’ipotesi particolare di danni da cose in custodia” gravante sul proprietario, “con la conseguenza che, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce l’applicazione dell’art. 2051 c.c. spettante al proprietario per la violazione del dovere di vigilanza disposto dal citato art. 2051 c.c.” (peraltro, che la responsabilità ex art. 2053 c.c. rivesta sia la natura oggettiva sia il carattere di specialità, è stato, da ultimo, affermato anche da Cass. 21 febbraio 2023, n. 5368).
Invero, qui l’obbligo di custodia deriva dal titolo di proprietà – la norma lo esige espressamente –disegnando un istituto di responsabilità assai più specifico (perché automatico) di quello dell’art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità per “ciascuno” che abbia in custodia la cosa.
Piuttosto che prospettare un rapporto “gerarchico” genus-species – ad avviso degli ermellini – è maggiormente corretto, allora, ravvisare tra gli artt. 2051 e 2053 c.c. una “interserzione strutturale”, avente ad oggetto, appunto, la custodia.
La custodia, nell’art. 2051 c.c. deriva da un’effettiva e concreta posizione di un “potere di fatto”, mentre nell’art. 2053 c.c. deriva solo da un “titolo di diritto”, ossia la proprietà.
Per adeguare, peraltro, la responsabilità a quel che (prima ancora che giuridicamente, logicamente)costituisce il valutabile caso specifico, così che non sia oggettiva al punto da far gravare sul proprietario ogni evento di danno correlato in qualunque modo e misura al bene – una distorsione evidente della natura erga omnes del suo diritto – la norma indica un “limite tutelante”, che sùbito porta ad approssimare l’elemento sostanziale con uno strumento difensivo, e, quindi, tendenzialmente processuale – tanto che si è ravvisato un’attività di difesa a fronte di una presunzione legale di responsabilità – nel fatto che il proprietario (“salvo che provi”) possa dimostrare che la rovina “non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
Il difetto di manutenzione o il vizio di costruzione – quest’ultimo, d’altronde, per riverberarsi su un obbligo di custodia non può non essere almeno conoscibile – conducono, con evidenza, ad una carenza di custodia, e la custodia, che è, appunto, obbligo ontologicamente insito nella proprietà, costituisce l’elemento che accomuna l’art. 2053 c.c. in parte qua all’art. 2051 c.c., ossia con la fattispecie di responsabilità custodiale “pura”.
Invero, nel caso (speciale) della rovina di edifici, la posizione del proprietario è, nella sostanza, anche quella di custode, ma, al contempo, non si può giungere a ritenere che la proprietà tout court generi sempre la responsabilità, qualunque sia l’evento che della proprietà abbia coinvolto l’oggetto.
Proprio per questo “intreccio” dei due paradigmi e, quindi, al fine di non sbagliare nell’individuazione del rapporto sistemico con l’art. 2051 c.c., occorre identificare correttamente – secondo il parere dei magistrati del Palazzaccio – il limite della responsabilità ex art. 2053 c.c.
Responsabilità, questa, palesemente “oggettiva”, perché discendente in via diretta dalla titolarità del diritto reale sul bene, laddove il limite è stato collocato dalla magistratura di vertice – così convalidando le radici della responsabilità come sussistenti nella titolarità del diritto in sé – sul piano della presunzione legale, avvalendosene per concretizzare le modalità, e anche lo “spazio”, della prova liberatoria.
Già in una remota pronuncia (v. Cass. 20 dicembre 1976, n. 4694), si era rinvenuta la netta affermazione che l’art. 2053 c.c. grava il proprietario di una presunzione legale di responsabilità per i danni da rovina del suo edificio per vizi di costruzione o difetto di manutenzione, cioè dovuti ad una causa che “il proprietario è tenuto evitare per il suo peculiare dovere di cura e vigilanza su costruzioni potenzialmente dannose per i terzi”.
E questa responsabilità, radicandosi sul diritto reale, non viene meno soltanto perché il proprietario ha affidato ad altri l’immobile, per la costruzione di un edificio o per un godimento temporaneo: tali circostanze, da sole, possono generare unicamente un concorso di colpa e, quindi, una rivalsa nei confronti del terzo, o,comunque, ridurre la responsabilità del proprietario, essendo escludibile la responsabilità del proprietario dell’immobile soltanto per quanto avviene come causato da fattori “esterni” – segnatamente, caso fortuito eforza maggiore – rispetto alla sua sfera di azione (su questa linea, v. anche Cass. 14 gennaio 1988, n. 212).
Seguendo tale impostazione ermeneutica, si è statuito (v. Cass. 12 marzo 2004, n. 5127) che l’art.2053 c.c. pone a carico del proprietario di un edificio una responsabilità legale presunta, che può esserevinta, senza che si dia luogo necessariamente al concorso di responsabilità del proprietario dell’edificio, qualora si provi l’esistenza di un’altra causa dell’evento dannoso avente “un’efficienza causale del tutto autonoma ed esclusiva rispetto al vizio di costruzione o al difetto di manutenzione”, ivi compreso il fatto del terzo e dello stesso danneggiato.
Esimente, quest’ultima, che, “in quanto comune ad ogni forma di responsabilità, assume portata generale”, così da porsi “sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall’art. 2051 c.c., potendo configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale” (così Cass. 14 ottobre 2005, n. 19974, nel caso di un improvviso e imprevedibile fenomeno naturale atto a “travolgere ogni baluardo posto a salvaguardia”).
In quest’ottica, il coevo arresto (v. Cass. 14 ottobre 2005 n. 19975) sottolinea che bisogna anche considerare “il concorso tra la colpa presunta del proprietario e quella accertata in concreto del danneggiato,il quale, con la propria condotta, abbia agevolato o accelerato la rovina”; ed altra pronuncia (v. Cass. 15 settembre 2008, n. 23684) afferma che la responsabilità del proprietario per la rovina di edificio ai sensi dell’art. 2053 c.c. sussiste quando i danni derivano, oltre che da difetti originari e da attività da lui svolte nell’interno dell’immobile, anche dal comportamento dei terzi immessi nel suo godimento, come nel caso della locazione.
Il limite della responsabilità oggettiva “del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento” per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. viene ancora ribadito (v. Cass. 21 gennaio 2010, n. 1002) come identificabile in un fatto dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, includendo, in una siffatta “area causale esterna”, idonea a derivare di responsabilità il proprietario, pure il fatto esterno non imprevedibile/inevitabile.
Ad ogni buon conto – ad avviso dei magistrati del Palazzaccio – qualunque via interpretativa percorra il ragionamento, in ultima analisi, o la qualificazione presuntiva di una globale responsabilità derivante dal diritto di proprietà, oppure anche l’identificazione diretta del confine di una responsabilità realmente sussistente e, quindi, non soltanto legalmente presunta – la seconda via è quella che appare maggiormente sintonica al dettato letterale, ma è l’altra che, da tempo, è percepibile nell’interpretazione giurisprudenziale –permane la validità, in iure, del risultato, da entrambe le vie raggiungibile, dell’assenza di responsabilità dell’originario convenuto, proprietario del capannone confinante coinvolto nell’incendio, avendo il giudice di merito accertato, in facto, la sussistenza dell’elemento diretto ad infrangere la presunzione legale di responsabilità o che, comunque, oltrepassa il perimetro di responsabilità come delineato dall’art. 2053 c.c.
Invero, il CTU aveva acclarato che “il danno era stato provocato direttamente dall’incendio, elemento diverso dagli elementi strutturali della costruzione”, e che “non vi era stata alcuna connessione tra le anomalie strutturali e l’incendio o l’aggravamento di esso”.
Particolarmente discusso è se le condizioni meteorologiche, esistenti al momento della rovina,possano costituire una prova liberatoria: l’eterogenea casistica affrontata dai giudici di merito registra che si è esclusa la sussistenza del caso fortuito in presenza di fortissimo vento, di turbini d’aria a 76 km/h, di raffiche di bora a 122 km/h a Trieste e di tromba marina, mentre è stato riconosciuto lo stesso caso fortuitoper un nubifragio di eccezionale violenza e per le piogge straordinarie nella zona del Monferrato.