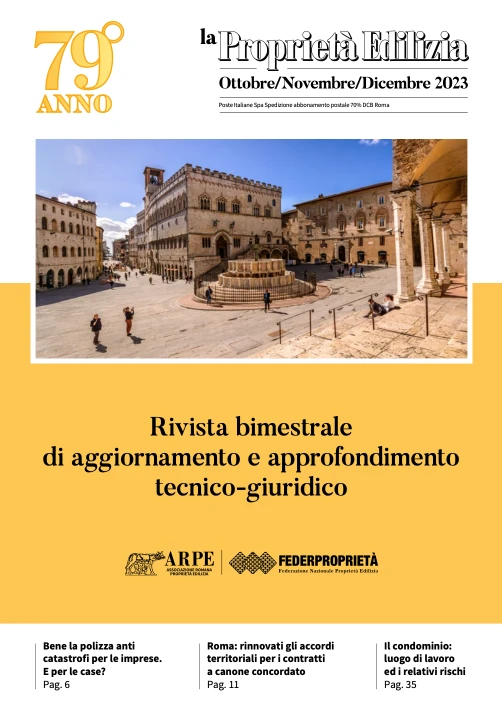Con la recente sentenza n. 3925 del 13 febbraio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazionehanno risolto l’annosa questione relativa alla possibilità di costituire una servitù avente ad oggetto il parcheggio di un’auto, con tanto di transito e manovra, sul fondo altrui.
In effetti, si registrava un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità di costituire e riconoscere servitù prediali di parcheggio, atteso che le prime pronunce dei giudici di Piazza Cavour – v., tra le altre, Cass. n. 8137/2004, Cass. n. 20409/2009, Cass. n. 15334/2012, e Cass. 23708/2014 – avevano negato la configurabilità di una servitù di parcheggio/posteggio per assenza del requisito della “realità”(proprio del diritto di servitù).
Successivamente, i giudici di legittimità hanno operato, invece, un’inversione di tendenza perché, discostandosi dal filone che seguiva la tesi restrittiva, hanno ammesso, a certe condizioni, la possibilità di costituzione della servitù di parcheggio (v., soprattutto, sull’abbrivio di Cass. n. 16698/2017, a seguire Cass. n. 7561/2019, Cass. n. 12798/2019, Cass. n. 24121/2020, Cass. n. 193/2020, Cass. n. 1486/2023, e Cass. n. 7620/2023, laddove Cass. n. 40824/2021 non si pone in dissonanza con tale impostazione).
In quest’ordine di concetti, il supremo organo di nomofilachia ha aderito a quest’ultimo orientamento favorevole alla configurabilità, a determinate condizioni, di una convenzione istitutiva di una siffatta servitù.
Innanzitutto, si concorda con l’impostazione che vede un’indubbia affinità tra il transitare o il parcheggiare un’autovettura all’interno di un fondo di proprietà altrui, perché, in entrambi i casi, i proprietari di fondi confinanti, in base al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., possono dar luogo sia ad un rapporto di natura reale – attraverso l’imposizione di un peso sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante e, quindi, in una relazione di asservimento del primo al secondo, che si configura come qualitas fundi – sia alla pattuizione di un obbligo e di un corrispettivo diritto previsto a vantaggio e per la comodità della persona o delle persone specificamente indicate nell’atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria.
Vi è, poi, un argomento di ordine sistematico di indubbia rilevanza, rappresentato dalla legislazione sui vincoli di parcheggio: a partire dalla legge n. 765/1967, infatti, il legislatore ha mostrato di favorire la destinazione di spazi privati a parcheggio, al fine di decongestionare gli spazi pubblici.
In termini generali, quando il legislatore, con l’art. 18 della legge n. 765/1967, ha introdotto l’art. 41–sexies della legge urbanistica prevedendo che, nelle nuove costruzioni, debbano essere riservati spazi a parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadro per ogni dieci metri di costruzione, ha condizionato l’edificabilità del fondo alla disponibilità del parcheggio, sicché, sul piano sistematico, diventa difficile negare che l’utilità del parcheggio sia strettamente inerente (anche) al fondo.
Del resto, gli ermellini hanno ripetutamente affermato che, in tali casi, si configura un “diritto reale d’uso” in favore dei condomini (v. Cass. n. 1214/2012, Cass. n. 21003/2008, Cass. n. 2265/2019); e allora, una volta ammessa pacificamente l’esistenza di un diritto reale di uso sulle aree da destinare a parcheggio, coerentemente non si può negare l’ammissibilità della costituzione di una servitù di parcheggio per difetto dell’inerenza al fondo, perché ciò comporterebbe una contraddizione in termini: il parcheggio non sarebbe utile al fondo nonostante ne condizioni addirittura l’edificabilità.
L’orientamento restrittivo ha sempre affrontato la tematica dando per assodato che, nella servitù di parcheggio, l’utilità inerisca alle persone e non ai fondi, senza affrontare, però, specificamente il tema dell’estensione dei concetti di utilità ed inerenza, e senza particolari analisi del rapporto tra utilità per le persone e utilità per i fondi che non sono alternative, ma ben possono coesistere.
Un argomento ulteriore a favore del possibile inquadramento del rapporto tra parcheggio e bene immobile all’interno della categoria delle servitù prediali – secondo l’autorevole parere dei magistrati del Palazzaccio – lo si trae anche dalla sentenza n. 167/1999 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1052, comma 2, c.c., nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo possa essere concesso dal giudice quando si riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità – di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap – degli edifici destinati ad uso abitativo.
Invero, dalla lettura della pronuncia dei giudici della Consulta, emerge il seguente passaggio, seppure relativo alla legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, che costituisce un ulteriore contributo all’espansione della nozione di utilità: “il legislatore ha configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili, anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione, a prescindere dalla loro concreta appartenenza a soggetti portatori di handicap, mentre dottrina e giurisprudenza hanno, per altro verso, chiarito come la predialità non sia certo incompatibile con una nozione di utilitas che abbia riguardo – specie per gli edifici di civile abitazione – alle condizioni di vita dell’uomo in un determinato contesto storico e sociale, purché detta utilitas sia inerente al bene così da potersi trasmettere ad ogni successivo proprietario del fondo dominante”.
Inoltre, la tesi favorevole alla costituzione della servitù, oltre ad essere in linea con il sistema, esalta anche il fondamentale principio dell’autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), che, però, non sfocia in una libertà illimitata, dovendosi sempre confrontare con il limite della meritevolezza di tutela degli elementi dell’accordo.
Del resto – come già rilevato anche dalle stesse Sezioni Unite (v. Cass. S.U. n. 8434/2020, in una vicenda condominiale sulla concessione di un lastrico solare in godimento ad un terzo per l’installazione di impianti tecnologici) – non vi è ragione per negare alle parti la possibilità di scegliere, nell’esercizio dell’autonomia privata riconosciuta dall’art. 1322 c.c., se perseguire risultati socio-economici analoghi, anche se non identici, mediante contratti ad effetti reali o ad effetti obbligatori; come si verifica, ad esempio, in relazione all’attribuzione del diritto di raccogliere i frutti dal fondo altrui (che può essere conseguita attraverso un contratto costitutivo del diritto di usufrutto o attraverso un contratto attributivo di un diritto personale di godimento, lato sensu riconducibile al modello del contratto di affitto) o in relazione all’attribuzione del diritto di attraversare il fondo altrui (che può essere conseguita attraverso un contratto costitutivo di una servitù di passaggio o attraverso un contratto attributivo di un diritto personale di passaggio).
Il principio di “tipicità legale” necessaria dei diritti reali si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle prevista dalla legge e – secondo il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28972/2020, con la quale è stato affermato che, proprio per effetto dell’operatività del principio appena richiamato, è da ritenere preclusa la pattuizione avente ad oggetto l’attribuzione del c.d. diritto reale di uso esclusivo di una porzione condominiale – tale caratterizzazione è supportata anche dagli argomenti secondo i quali: a) l’art. 1322 c.c. colloca nel comparto contrattuale il principio dell’autonomia; b) l’ordinamento mostra di guardare sotto ogni aspetto con sfavore a limitazioni particolarmente incisive del diritto di proprietà; c) l’art. 2643 c.c. contiene un’elencazione tassativa dei diritti reali soggetti a trascrizione.
Tornando al tema specifico della servitù di parcheggio e riprendendo il passaggio motivazionale di Cass. n. 16698/2017, la tesi favorevole alla costituzione della servitù di parcheggio valorizza il “concetto di tipicità strutturale”, ma non contenutistico della servitù.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, l’autonomia contrattuale è libera di prevedere una utilitas,destinata a vantaggio – non già di una o più persone, ma – di un fondo, che si traduca nel diritto di parcheggio di autovetture secondo lo schema, appunto, della servitù prediale e, quindi, nell’osservanza di tutti i requisiti del ius in re aliena.
Sotto quest’ultimo profilo – come già affermato dalle stesse Sezioni Unite (v. Cass. S.U. n. 28972/2020, cit.) – la servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall’angolo visuale dell’obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell’utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale.
Insomma, la costituzione della servitù, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, importa una restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, ma tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento dello stesso fondo servente.
Ciò posto, non vi è dubbio che lo stabilire se un contratto debba qualificarsi come contratto ad effetti reali o come contratto ad effetti obbligatori attiene alla “ermeneusi negoziale”, la cui soluzione compete al giudice di merito (v., tra le tante, Cass. S.U. n. 8434/2020, cit.).
Pertanto, nel dirimere il contrasto di giurisprudenza sopra delineato, le Sezioni Unite hanno riaffermato il principio di diritto per cui, in tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e, in particolare, la localizzazione.
Posta, dunque, la configurabilità, a determinate condizioni, della servitù di parcheggio, il magistrato sarà tenuto, di volta in volta, ad analizzare specificamente il contenuto della pattuizione secondo la volontà delle parti contraenti, verificando in concreto la sussistenza dei requisiti dello ius in re aliena, e segnatamente:
1) l’altruità della cosa;
2) l’assolutezza del diritto;
3) l’immediatezza (non necessità dell’altrui collaborazione, ai sensi dell’art. 1064 c.c.);
4) l’inerenza al fondo servente (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo servente potenzialmente in conflitto con la servitù);
5) l’inerenza al fondo dominante (l’utilizzo del parcheggio deve essere uno dei modi attraverso cui si estrinseca il vantaggio del fondo dominante, secondo la sua destinazione);
6) la specificità dell’utilità riservata (la servitù di parcheggio non potrà riguardare genericamente l’area assegnata, ma dovrà concretizzarsi nella sua specificità in quanto il proprietario del fondo dominante avrà diritto ad utilizzare l’area assegnata sul fondo servente al solo scopo di parcheggiare la propria autovettura);
7) la localizzazione, intesa quale individuazione esatta del luogo di esercizio della servitù (affinché non si incorra nell’indeterminatezza dell’oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà).